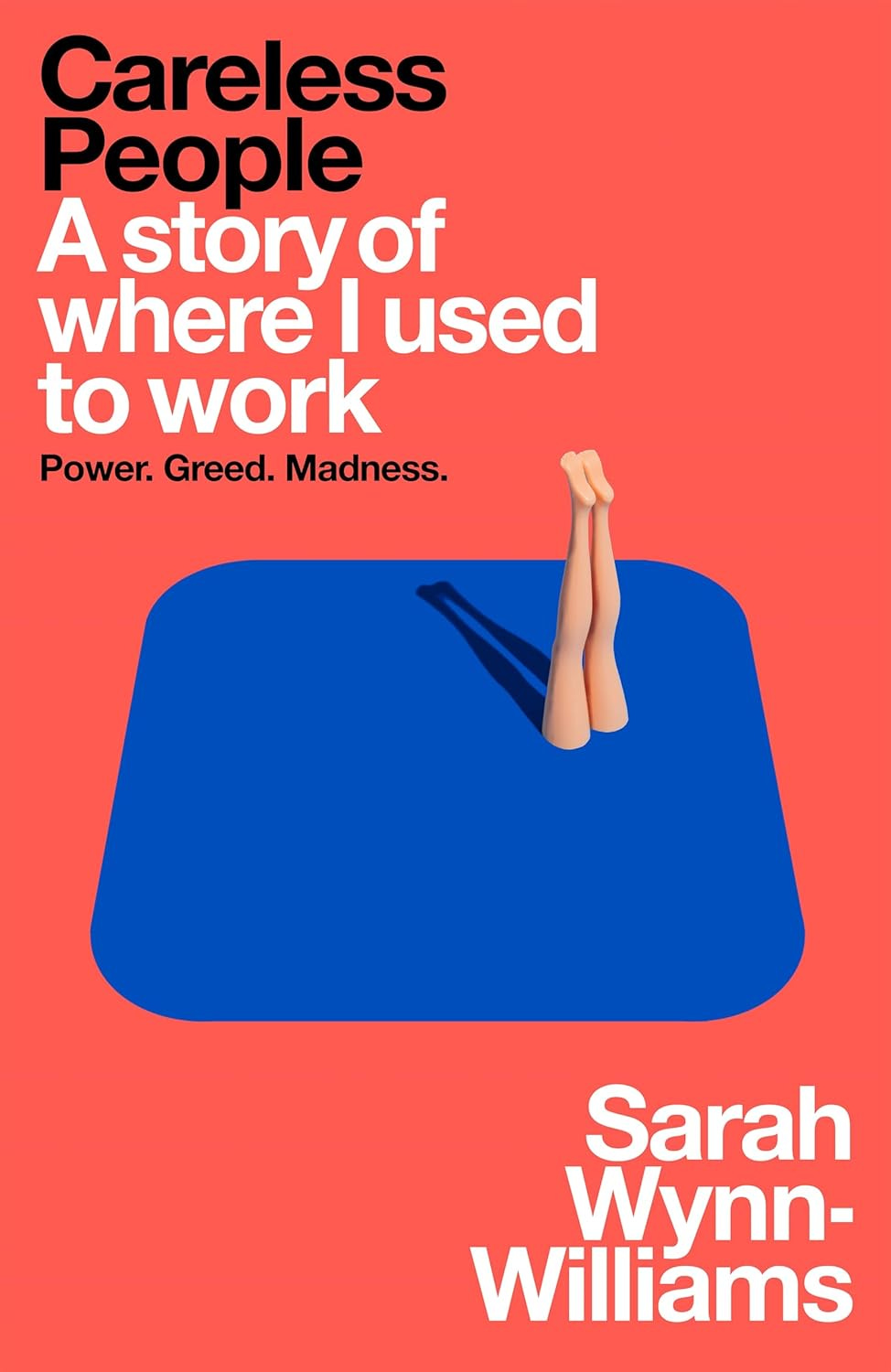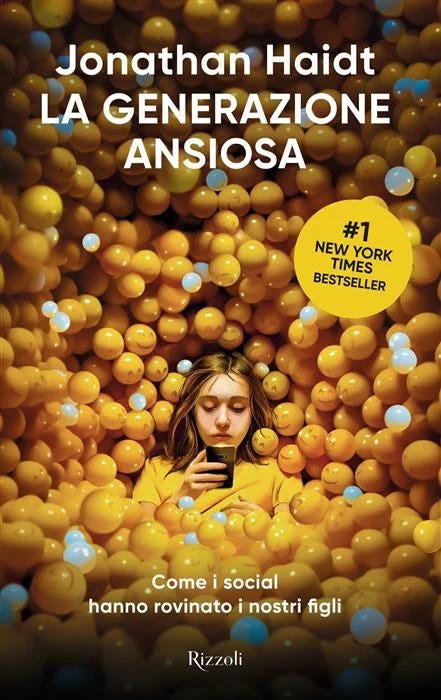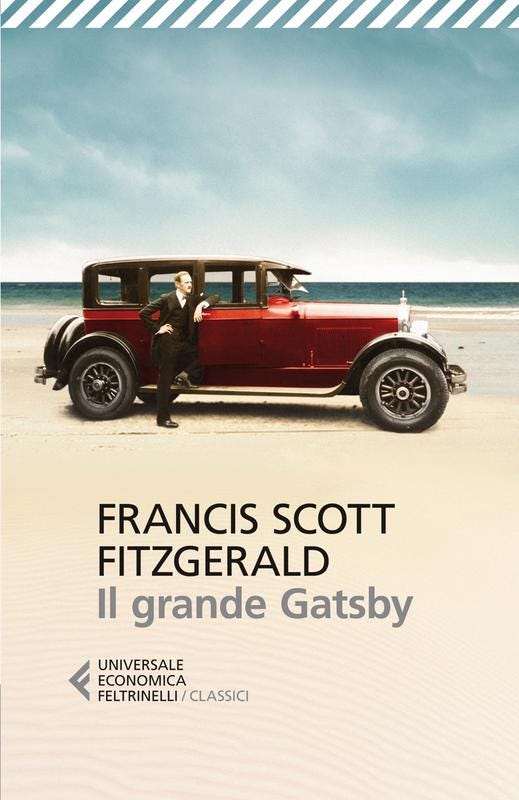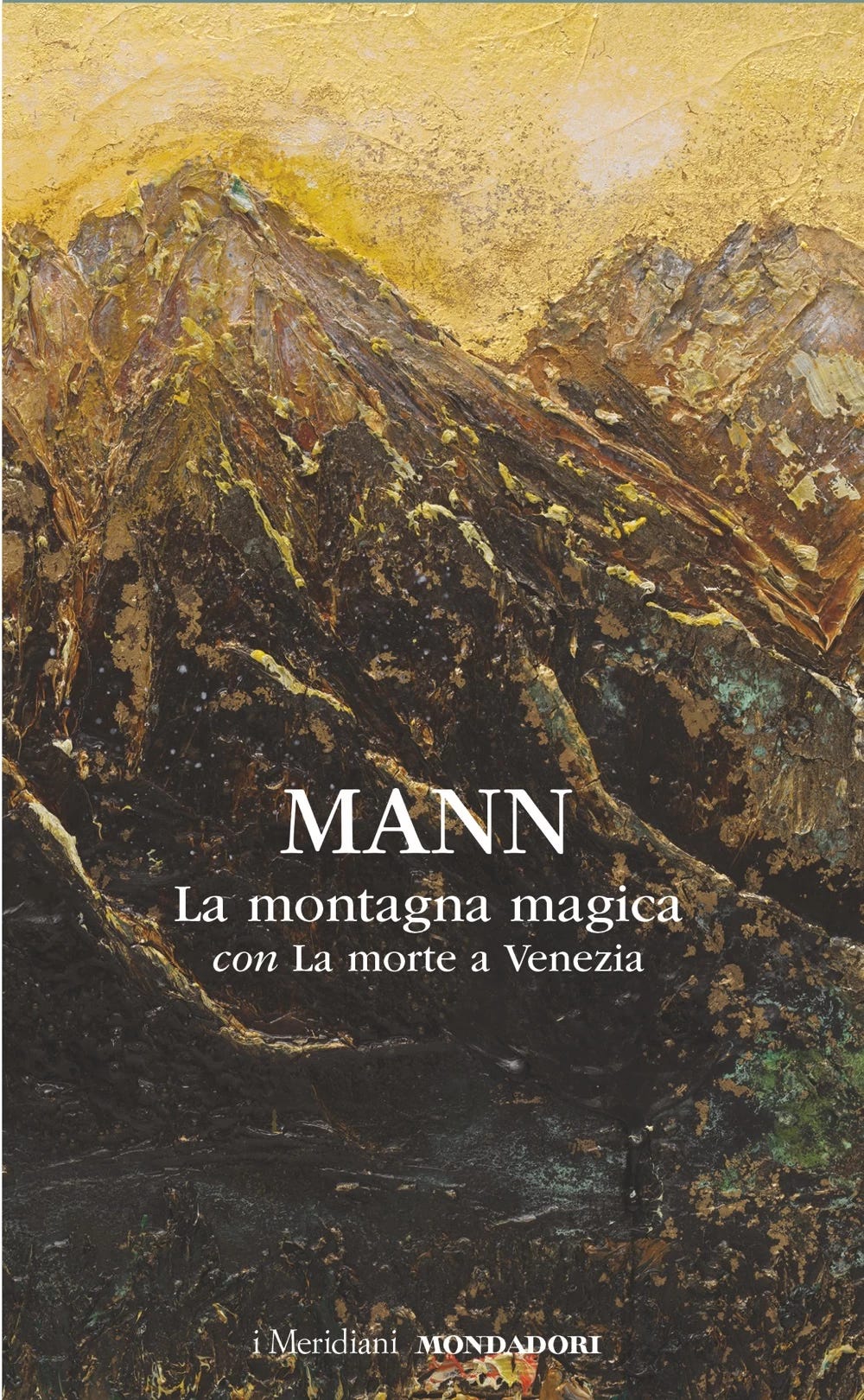Cosa è andato storto?
Il tema del momento: internet, da benedizione a iattura. Che fare? Leggere buoni libri, per esempio, e combattere così la frantumazione dell’attenzione, oltre che la crescente idiozia dei nostri tempi
Se con buona regolarità vi affacciate sul sito del «Corriere della Sera», nell’ultimo mese quasi sicuramente non vi sarà sfuggita una delle puntate che sulla sezione «Login» – quella che si occupa di tecnologia, innovazione e scienza – a cadenza settimanale Riccardo Luna sta dedicando al tema “Cosa è andato storto?”, da un certo punto in poi, nello sviluppo e nell’utilizzo di internet. Un’invenzione tecnologica – la più grande del Novecento, secondo Rita Levi Montalcini, e come prevalentemente appariva alla platea degli utilizzatori a cavallo del Duemila e ancora per tutti gli anni Zero del XXI secolo: uno strumento meraviglioso per stabilire connessioni, interagire con estrema facilità con persone di tutto il mondo e altrettanto facilmente accedere a contenuti di ogni tipo, arricchendo in tal modo le nostre conoscenze e migliorando dunque la vita individuale e collettiva – che, a parere di molti, in un quindicennio scarso si è trasformata in una macchina diabolica che, in misura crescente, fa parlare di sé più per i guasti che ha provocato e quelli ulteriori che si avvia a produrre che non per i benefici che ha arrecato a ciascuno di noi e all’umanità nel suo complesso.
Le puntate già uscite sono quattro: la prima il 10 marzo, intitolata “Internet, da ‘dono di Dio’ a pericolo per la democrazia: cosa è andato storto?”; la seconda il 17 marzo, “Facebook, da accogliente ritrovo di vecchi amici a luogo di ‘distorsione collettiva della realtà’: cosa è andato storto?”; la terza il 24 marzo, “Il business della rabbia: da TikTok a Facebook, quando l’algoritmo gioca con il nostro cervello. Cosa è andato storto?”; la quarta il 31 marzo, “Così il vento di Facebook ha alimentato il populismo. Cosa è andato storto?”. Da martedì 8 marzo sarà online la quinta.
Perché torno a scrivere su «Le didascalie» dopo un silenzio di tre mesi – un inizio di 2025 che fino a metà febbraio mi ha visto impegnato nella traduzione di un libro che dovrebbe uscire a maggio, e di cui al momento posso dire soltanto che è un saggio su Israele e Palestina, dopo i fatti del 7 ottobre 2023 e la successiva brutale guerra a Gaza, autore il giornalista statunitense
; il mese e mezzo a seguire mi sono invece dedicato prevalentemente alla lettura, con i titoli che indicherò più sotto – prendendo spunto proprio dal tema “Cosa è andato storto?”, su e con internet, a cui il «Corriere della Sera» sta ora dando tanto spazio, con la serie di articoli a cadenza settimanale di Riccardo Luna?La spiegazione è semplice: come molti di coloro che hanno cominciato a fare un uso importante della “rete delle reti” suppergiù dalla seconda metà degli anni Novanta, sul principio sono stato follemente innamorato di internet e delle fantastiche possibilità che consentiva: non esito a dire che mi ha cambiato la vita, e ampiamente in positivo, a livello sia professionale sia personale, umano, persino caratteriale.
Del periodo che abbraccia grosso modo gli anni dal 1995 al 2012 – gli anni che vanno dall’approdo su internet con gli allora lenti e rumorosi modem 14K o 28K e le costose connessioni tramite linea telefonica ordinaria, con la tariffa urbana a tempo, in aggiunta all’abbonamento con un provider locale, fino ai primi cambi di gestore telefonico per avere la migliore connessione Adsl possibile, senza limiti di tempo e a prezzi contenuti, ma senza ancora portarsi dietro internet 24 ore su 24, e in qualunque posto, grazie a uno smartphone; o, se vogliamo, gli anni delle mailing list e delle mail a raffica, seguiti da quelli spumeggianti dei blog, fino alle prime esperienze con Tumblr, Twitter e Facebook – nutro ricordi e giudizi in larga parte soddisfacenti.
Sull’intero periodo successivo – con gli smartphone nelle tasche e, più ancora, nelle mani di chiunque; con un po’ tutti divenuti schiavi e vittime dei social, di un bisogno inconsulto di visibilità e di esprimerci su tutto, affamati di like e riscontri, di “amici” e di follower, incessantemente attaccati a WhatsApp per mandare e ricevere foto, video, vocali, auguri, emoji, link non richiesti, comunicazioni minute, stronzate e falsità multiple a non finire; con le notifiche a getto continuo sui cellulari a menomare una capacità di attenzione e concentrazione già ridotta ai minimi termini e, di fatto, una salute mentale di piccoli e grandi vistosamente deteriorata; per non parlare delle crescenti divergenze di opinione e delle reciproche insofferenze, anche nell’ambito dei presunti “amici” – prevalgono invece le riserve, se non le bocciature senza appello.
Non è allora il caso di domandarsi che cosa sia andato storto, almeno da una dozzina di anni in qua, e che cosa fare, ora, per provare a raddrizzare un po’ la situazione? Per me, negli ultimi tempi, questa è diventata una questione pressante, non più eludibile.
E se l’arrivo di Musk al timone di Twitter e la sua successiva trasformazione in X sono stati i fattori che mi hanno spinto a interrompere definitivamente la mia presenza su quel social, divenuto invivibile, il fragoroso ritorno alla Casa Bianca di Trump, con il codazzo dei capi di tutte le Big Tech ossequiosamente prostrati ai suoi piedi, e il delirio generale che ciò ha immediatamente messo in moto sono, da ultimo, poche settimane fa, all’origine della decisione di uscirmene di nuovo anche da Facebook, stavolta forse per sempre.
Dico «stavolta forse per sempre» perché la lettura di Careless People: A story of where I used to work, il libro testimonianza di Sarah Wynn-Williams sui suoi anni come responsabile delle politiche pubbliche globali di Facebook (memoir uscito a inizio marzo, senza che prima se ne avesse notizia, e che subito ha prodotto il tentativo di Meta di bloccarne a ogni costo la circolazione, visti i contenuti fortemente critici. Questo non ha però impedito che diventasse il bestseller del momento; anzi, in un perfetto esempio dell’“effetto Streisand”, il maldestro tentativo di censura ha solo proiettato il libro ai primi posti delle classifiche di vendita), è stato il colpo di grazia sul mio già contrastatissimo rapporto con FB.
E come se ciò non bastasse, cosa ho letto subito dopo? La generazione ansiosa. Come i social hanno rovinato i nostri figli, il saggio dello psicologo sociale Jonathan Haidt (qui su Substack con la newsletter «
»), a sua volta un bestseller, sui guasti che l’accoppiata smartphone-social ha prodotto nella vita un po’ di tutti, ma in particolare in quella dei più giovani, a partire dai primi anni Dieci andati incontro a un vistoso calo della salute mentale.E ancora, a seguire, che ho letto? Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald, il romanzo degli anni Venti del secolo scorso da cui è tratto il titolo Careless People del succitato memoir di Sarah Wynn-Williams, con riferimento a quei ricchi incuranti e «sventati» – per rifarci alla traduzione Feltrinelli di Franca Cavagnoli – come il Tom e la Daisy di Fitzgerald, ma anche come i Mark Zuckerberg, gli Elon Musk o le Sheryl Sandberg di oggi, che «rompevano cose e creature e poi si ritraevano nei loro soldi o nella loro vasta sventatezza, o qualunque cosa fosse a tenerli insieme, e pretendevano che fossero gli altri a ripulire lo sporco che avevano lasciato in giro».
Insomma, leggi uno dietro l’altro tre libri come quelli di cui sopra e stai pur certo che ti passerà la voglia di stare ancora sui social, a partire da quelli dell’universo Meta.
Prima di questo bel terzetto di volumi, già in fase di detox da Facebook e dagli ultimi avvilenti sviluppi internazionali, nonché dall’ultima e non meno avvilente traduzione a sfondo bellico, mi ero comunque regalato una corposa e importante lettura, a lungo accarezzata ma sempre rinviata: La montagna magica di Thomas Mann, di cui nel 2024 si è celebrato il centenario (consigliato, al riguardo, il pezzo “The Apostle of Love” scritto da Merve Emre per la «Yale Review»). E che dire? Le mille e passa pagine, note e prefazione escluse, dell’edizione dei Meridiani Mondadori, nella rinnovata – già nel titolo – traduzione di Renata Colorni, sono state alquanto impegnative; ma vuoi mettere la soddisfazione di arrivare alla fine in poco più di due settimane?
Leggere 100-150 pagine al giorno, quando uno ci si mette, che sia un romanzo, un memoir o un saggio, è segno che ancora la capacità di concentrazione e attenzione non è andata del tutto a farsi benedire, a dispetto di quanto smartphone e social facciano di tutto per metterci mentalmente – e socialmente – kappaò.
Posso allora permettermi un consiglio finale? Leggete quello che vi sta più a cuore, ma leggete, se possibile anche libri di un numero consistente di pagine: è un modo di resistere alla frantumazione dell’attenzione a cui siamo quotidianamente sottoposti, non ultimo con le notifiche continue che arrivano su cellulari e tablet. E se vi volete davvero bene, ma non ancora al punto di uscire per sempre da questo o quel social, disattivate se non altro il maggior numero possibile di notifiche. E durante il lavoro, così come durante la stessa lettura, ma anche in altre occasioni, ogni tanto mettete lo smartphone in Modalità aereo: fidatevi, ci si guadagna in benessere mentale.
Alla prossima, spero con maggiore leggerezza (anche se il nuovo libro da tradurre, di nuovo su Israele e Palestina, non lascia ben sperare).
Un postscritto, che comunque si riaggancia a quanto sopra e riguarda il libro finito di leggere il giorno dopo la pubblicazione di questo post e l’invio della relativa newsletter: Il gelso di Gerusalemme. L’altra storia raccontata dagli alberi, di Paola Caridi, pubblicato da Feltrinelli nel settembre 2024. Davvero bello. L’autrice, giornalista e saggista, esperta del mondo arabo, ci conduce in un viaggio – cito dalla quarta di copertina – alla scoperta delle «storie dietro agli alberi – e ai giardini botanici – più simbolici del Medio Oriente e del Mediterraneo. E con queste storie – sorprendenti, personali, politiche e tragiche – fa vivere anche le storie degli uomini e delle donne che hanno deciso di abitare la terra dove questi alberi hanno messo radici».