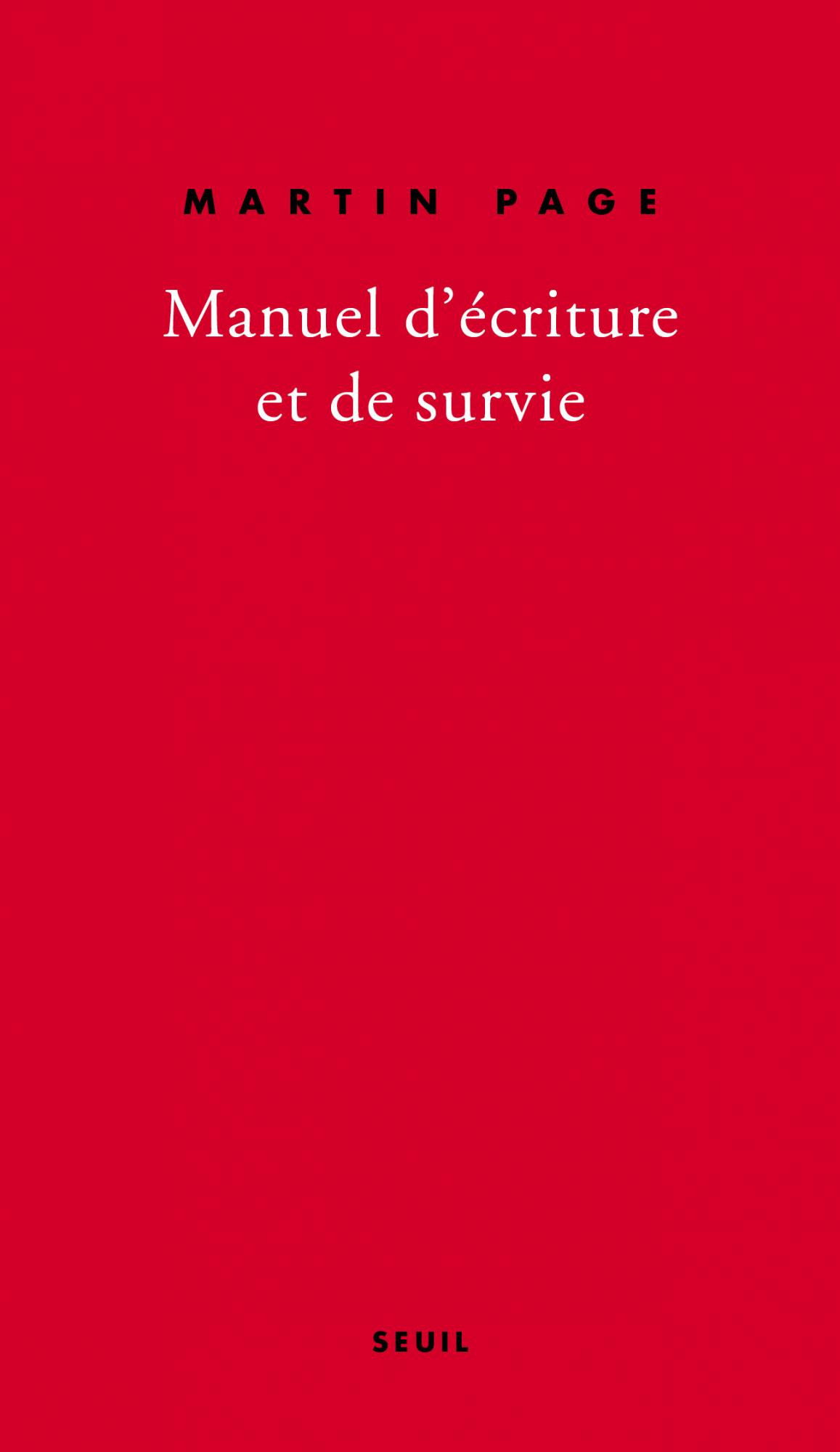Martin Page, “Manuel d’écriture et de survie”
In poche parole, quando il traduttore disoccupato si fa prendere dalla voglia di tradurre tutto quello che legge, se gli piace davvero, per poi non farsene (quasi) niente
Nel luglio del 2018 mi capitò, via Twitter, di venire a conoscenza di un libro che già dal titolo mi incuriosiva: Manuel d’écriture et de survie, dello scrittore francese Martin Page (Parigi, 1975), pubblicato da Seuil nel 2014. Libero da impegni professionali e in attesa di portare a termine alcuni lavori edili a casa, non solo lo lessi, trovandolo di mio pieno gradimento, ma per puro diletto ne intrapresi una rapida traduzione, giusto per tenermi un po’ occupato e non arrugginirmi del tutto con il francese, non la mia lingua di lavoro abituale. Alla fine ci presi talmente gusto che nel giro di poche settimane lo tradussi per intero, approfittando anche della brevità (176 pagine, molto snelle). Confesso che in seguito provai anche a contattare la casa editrice italiana che di recente aveva pubblicato altri testi di Martin Page, per sondare un suo eventuale interesse, ma non ricevendo risposta, e di nuovo preso da impegni vari, non insistetti oltre. In una cartella del computer mi ritrovo allora questa traduzione completa che aspetta solo di essere rivista per bene, ma della quale in realtà non mi curo nemmeno più di tanto: è stata giusto un modo di tenermi in allenamento in un periodo in cui ero sostanzialmente preso da tutt’altre faccende. Comunque, visto che di questo libro ne so qualcosa, in base alla classica “filosofia del maiale” per cui non si butta via (quasi) niente ne fornirò sotto una breve sinossi.
Come recita il titolo, è un testo che parla di scrittura, ma non si tratta di un vero e proprio manuale: è una corrispondenza che l’autore intrattiene con una giovane ammiratrice e scrittrice (penso fittizia), di nome Daria, a sua volta intenta a scrivere un romanzo, dopo aver esordito con un racconto. Ci vengono presentate solo le lettere scritte dall’autore. Il tutto è dunque un pretesto per fornire una serie di consigli, ma in special modo per gettare una luce sulla vita degli scrittori di oggi, il loro lavoro, i rapporti reciproci e quelli con le case editrici, i lettori ecc. Alla fine, è sostanzialmente un autoritratto dell’autore stesso, alle prese con le sue nevrosi, i suoi interrogativi e anche i suoi momenti di esaltazione. È un testo ben fatto, non banale, direi pure simpatico.
A seguire, un piccolo assaggio dalla mia (provvisoria) traduzione.
Daria,
avendo già scambiato diverse lettere penso di poter dire che abbiamo avviato una corrispondenza. Me ne rallegro. D’ora in poi ti darò del tu, se non ti dispiace.
Mi scuso per il ritardo. Ho ricevuto la tua missiva già da qualche giorno, ma il mio intrepido gatto si è fatto male, così io e la mia compagna abbiamo dovuto portarlo dal veterinario. Adesso, a casa, gli abbiamo anche allestito un comodo angoletto per la sua convalescenza. Non è il tipico gatto dello scrittore. Non se ne sta placidamente disteso mentre scrivo. È sempre con il naso all’insù e gli occhi all’erta, gira per casa come fosse il suo regno.
Ma torniamo alla tua lettera.
Comprendo il tuo desiderio di essere chiamata una “scrittrice”. Si dice “chirurga”, “avvocata”, “panettiera”. La resistenza alla femminilizzazione degli appellativi dice qualcosa della posizione di subalternità ancora riservata alle donne e interiorizzata da molte di loro. È un tema spinoso nel mondo dei libri. La maggioranza dei lettori è costituita da donne, il personale delle case editrici è essenzialmente al femminile, ma sono ancora poche le donne che rivestono incarichi dirigenziali e quelle pubblicate sono meno degli uomini. Un’amica mi diceva di sentirsi meno autorizzata e legittimata degli uomini a rivendicare per sé lo status di scrittore. Ci sono ancora battaglie da fare. Tanto più che nell’ambiente letterario è molto diffusa la caricatura di rapporti di forza virilizzati (rapporti di forza esibiti ed applauditi dalle stesse donne). Tutto ciò che può rompere il dominio di un gruppo è utile (il dominio maschile opprime gli stessi uomini). La letteratura ha bisogno delle donne, dei poveri, delle minoranze, dei disadattati, di tutti coloro per i quali il mondo non è un’ovvietà.
D’ora in poi dirò dunque “scrittrice”. Suona bene. Hai notato la confusione che circonda il nostro appellativo? Un pittore è un pittore, un cantante è un cantante. Ma uno scrittore è, a seconda dei casi, un “autore”, un “romanziere”, uno “scribacchino”, uno “scrivano”, “uno che scrive libri”, e a volte uno “scrittore”. Questo si deve a due fatti, credo. Scrivere è un’arte che sembra accessibile a chiunque. Del resto bastano un foglio di carta e una penna, e scrivono tutti: attori, personaggi politici, sportivi, imprenditori. Di conseguenza la scrittura ha perso in nobiltà (tanto più che gli scrittori francesi sono restii a parlare di tecnica e di lavoro, a riflettere sul loro mestiere – negli ultimi anni mi vengono però in mente un paio di eccezioni). Non osi più dire che fai lo scrittore. Inoltre il peso della storia letteraria di questo paese intimorisce; anzi, diciamo pure che la storia letteraria viene ampiamente utilizzata per inibire la libertà degli scrittori. Alcuni affermano di non volersi assolutamente paragonare agli antichi maestri. Ma per quale folle ragionamento si finisce per pensare che definirsi uno scrittore sarebbe paragonarsi a Flaubert? Non ha alcun senso, se non quello di impedirci di usare questa parola. E la cosa funziona.
Io ci ho messo molto prima di dire che facevo lo scrittore. Quando ci provavo, avevo la sensazione di compiere un’usurpazione e allo stesso tempo avanzare una pretesa, come se la parola fosse troppo prestigiosa. La mia gioventù e la mia storia rendevano tutto difficile. A lungo sono perciò rimasto sul vago, dicendo che scrivevo libri (un piacevole vantaggio di questa indeterminatezza era che così potevano anche immaginarmi autore di libri di cucina o di yoga). È un problema diffuso di cui si discute tra amici.
Novizio del mondo letterario, vedevo come la sacralizzazione servisse a mascherare questioni di etica e di potere. Tutto concorreva ad avvalorare il mio sentirmi fuori luogo. “Scrittore” era troppo elegante e troppo bello.
Il compito di uno scrittore dovrebbe essere rendere giustizia alle parole. Sono la sua materia, le deve proteggere da ogni utilizzo improprio e malevolo. C’è una difesa della lingua da portare avanti, e non si tratta della salvaguardia convenzionale di una dieresi su una data parola o di qualche arcaismo grammaticale. Si parte dal rifiuto di abbandonare le parole alla condizione loro riservata. Non bisogna permettere che siano usurpate. Leggiamo senza posa Karl Kraus e Victor Klemperer. Le parole sono importanti. Il primo dizionario della lingua inglese fu redatto da Robert Cawdrey, contestatore e grande ribelle verso le autorità dell’epoca: la lingua è una questione esistenziale e politica. È questo il terreno su cui combattiamo.
“Scrittore” è un appellativo che si addice a noi e a chiunque scriva con ambizioni artistiche: sceneggiatori, autori di pièce radiofoniche, di romanzi, di serie televisive, di libri per ragazzi, di canzoni, di poesia, di saggi, di un blog. Non lasciamolo a chi ne fa uno strumento mondano e di prestigio. Il modo più giusto di utilizzare tale termine è farlo con semplicità e senza paura. Ciò rende giustizia alla bellezza così come alla quotidianità di questo artigianato. Essere uno scrittore non è un segno di distinzione, ma un’eccitante attitudine all’ossessione, all’osservazione e all’immaginazione. È un know-how, sono delle tecniche, un lavoro costante, un modo di vivere così come un modo di guadagnarsi da vivere. Ci sono voluti anni prima che potessi utilizzare questo appellativo senza provare disagio. Non c’è nulla di male: alcuni vestiti non sono belli e comodi finché non se ne fa un ampio uso e non acquisiscono una loro patina.
Fai bene ad appropriarti di questa parola, Daria. Il tuo percorso è stato più chiaro del mio. Tu non fai moine, non ti atteggi, non sei afflitta da un’irritante falsa modestia. È un sollievo.
Buona giornata, cara scrittrice, io vado a ripescare il gatto da sotto un mucchio di vestiti per dargli le medicine.
Martin
L’autore
Martin Page (Parigi, 1975) è autore di romanzi, saggi e libri per l’infanzia. Nel 2015, con Coline Pierré, ha fondato Monstrograph, una micro-casa editrice/laboratorio per testi atipici. In Italia suoi testi sono stati pubblicati da Garzanti (Come sono diventato stupido, 2002; Una perfetta giornata perfetta, 2003; La libellula, 2006; Forse una storia d’amore, 2009), Edizioni Clichy (L’apicoltura secondo Samuel Beckett, 2013; L’arte di rinascere, 2017), La nave di Teseo (Oltre la penetrazione, 2022) e ComicOut (Il club dei disadatt.i.e, 2022).